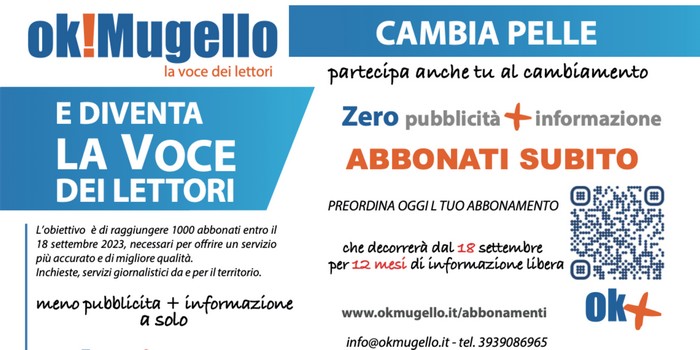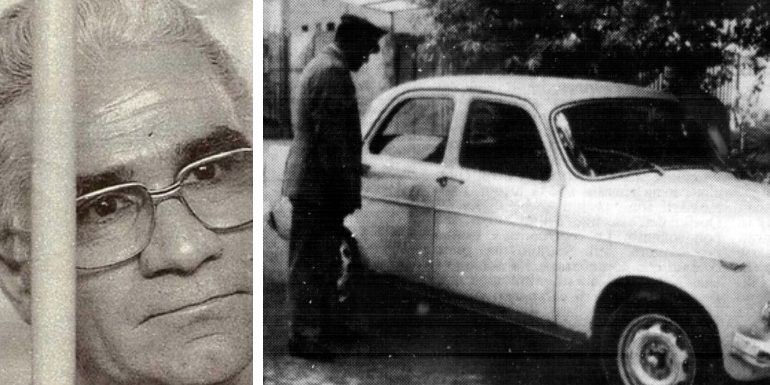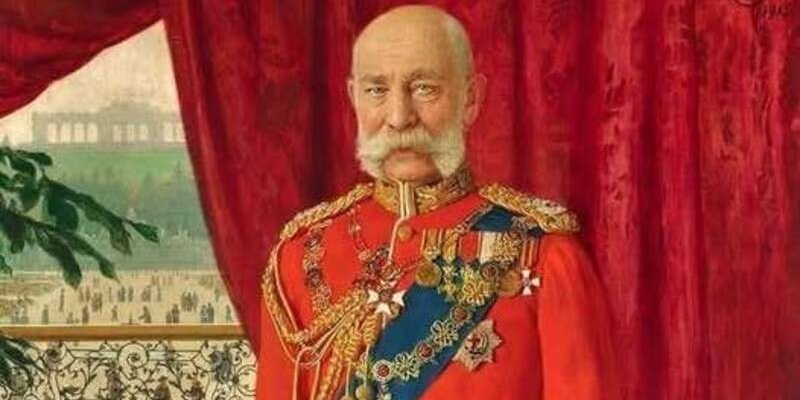arte etrusca © dp
arte etrusca © dp
Il testo che segue è un contributo del giornalista pubblicista Franco Giaccherini, che affronta un tema affascinante e dibattuto da secoli: da chi discendiamo noi Toscani? L’enigma delle origini etrusche ha alimentato una vasta letteratura, tra narrazioni greche spesso contraddittorie e ipotesi moderne sostenute da archeologia e genetica. Se in passato il dibattito oscillava tra una provenienza orientale e un’origine autoctona, gli studi più recenti, condotti da università internazionali e italiane, hanno confermato che gli Etruschi erano radicati nel territorio stesso, in continuità con la cultura villanoviana. Un popolo che, pur al centro di racconti mitici e visioni propagandistiche, appare oggi sempre più riconosciuto come autenticamente italico.
L’articolo di Franco Giaccherini
Ma da chi discendiamo noi Toscani?
Sull'origine e la provenienza degli Etruschi, con il passare degli anni, è nata una ingente quantità di letteratura, a volte attendibile, altre meno. E, del resto, ciò è abbastanza comprensibile. E ciò, non solo in ambito storico e archeologico. Tant’è che, a partire dalle teorie esposte quanto dalle fonti storiche, a partire circa dal V secolo a.C., ovvero cinquecento anni dopo le prime manifestazioni in Italia della civiltà Etrusca, molto di frequente le stesse sembrano in modo alquanto discordante. Considerate pur tuttavia palesi discordanti; e questa circostanza viene a mostrarci che sull'argomento ci fosse fra Greci ed Etruschi un’identità di visioni. Anche tenendo ben conto delle strette e continue relazioni commerciali e culturali fra Greci ed Etruschi, risulta abbastanza verosimile ritenere che gli stessi Etruschi non possedessero alcuna tradizione propria su una eventuale provenienza da altre parti del Mediterraneo o d'Europa; ma se tale tradizione fosse davvero esistita, gli stessi storici Latini e Greci l'avrebbero molto probabilmente riferita.
Certo, le tesi riguardo l'origine degli Etruschi, elaborate copiosamente sin dall'antichità, si potrebbero suddividere in due filoni e cioè: l'origine orientale e l'origine autoctona. Un terzo filone in merito all'origine settentrionale del popolo etrusco si basa su alcune considerazioni giunteci dallo stesso storico Tito Livio a proposito della popolazione alpina dei Reti, ma fu elaborato dagli storici solamente durante il XVII e il XIX secolo.
Le tesi antiche hanno dato vita a un lungo quanto assai acceso dibattito. Difatti, mentre gli studiosi moderni hanno messo in dubbio che le tesi antiche fossero o contenessero sempre fatti realmente accaduti, hanno concluso che per lo più fossero basate su invenzioni totalmente artificiose. Tutte le evidenze sino ad oggi raccolte dall'archeologia preistorica e protostorica, dall'antropologia e dalla genetica, sono in favore dell'origine autoctona degli Etruschi.
La parte e fase più antica della civiltà etrusca è la stessa cultura villanoviana, attestata a partire dal IX secolo a.C., che a sua volta deriva dalla cultura protovillanoviana (XII-X secolo a.C.).
Due studi di archeogenetica del 2019 e del 2021, ai quali hanno preso parte l'Università di Stanford, quella di Harvard, di Firenze e il Max Planck, hanno analizzato e pubblicato per la prima volta il DNA autosomico di campioni di resti etruschi provenienti dalla Toscana e dall'Alto Lazio, confermando che gli Etruschi fossero autoctoni, quindi simili sotto molti aspetti genetici ai Latini del Latinum vetus sin dall'età del ferro.
Critiche all'attendibilità delle tesi sull'origine degli Etruschi nella storiografia antica
L'etruscologo francese Dominique Briquel mette in evidenza come le versioni della storiografia greca sull'origine degli Etruschi siano da considerare costruzioni narrative artificiose, elaborate in ambienti ellenici o ellenizzati forse anche per scopi politici. Da ciò si deduce che non vadano considerate documenti storici.
Lo stesso a tal fine si esprime così:
"Le tradizioni tramandate dall'antichità sull'origine del popolo etrusco sono soltanto pura espressione dell'immagine che i suoi alleati o avversari volevano divulgare. Per nessun motivo racconti di un simile genere vanno considerati documenti storici. Certo, gli Etruschi a quei tempi furono oggetto di un vero e proprio dibattito, nel cui ambito – come denotano le osservazioni di Dionigi di Alicarnasso sull'isolamento della lingua etrusca – hanno avuto modo di emergere elementi di provata scientificità, come del resto anche molti ricordi di carattere storico-reale. Pur tuttavia, il discorso in sé mirava a una finalità ben precisa. E poiché gli attuali moderni hanno riacceso acriticamente la controversia, ricalcando le orme degli antichi, l’Etruscologia è stata così gravata dalla assai famigerata questione delle origini, che, giunti alla fine, è stata riconosciuta non pertinente nei termini in cui era stata posta".
(Dominique Briquel, Le origini degli Etruschi - una questione dibattuta sin dall'antichità, in M. Torelli (a cura di), Gli Etruschi, Milano, 2000, p. 43-51).
Infatti, i racconti degli autori greci sulle origini degli Etruschi, oltre che discordanti, sono redatti molti secoli dopo le prime attestazioni archeologiche degli Etruschi in Italia. Peraltro le fonti più antiche e parzialmente attendibili, come la Teogonia di Esiodo e anche un inno omerico, non fanno alcuna menzione a un’origine alloctona degli Etruschi.
I racconti greci, basati sul modello del racconto coloniale e sul mito di fondazione, sono il risultato di una rilettura di miti in chiave propagandistica – a volte antietrusca, altre volte protoetrusca – con evidenti mutamenti determinati dai cambiamenti nei rapporti politici tra Greci ed Etruschi. Le due vecchie tesi sull'origine orientale (quella pelasgica dalla Tessaglia e quella anatolica dalla Lidia) miravano a collegare le origini del popolo etrusco a un orizzonte etnico, culturale e geografico più vicino al mondo greco, mentre la tesi dell'autoctonia degli Etruschi mirava a sottolineare, con accezione dispregiativa, la distanza etnica e culturale che esisteva senza dubbio tra Etruschi e Greci.
Nota della redazione:
Questo articolo, firmato da Franco Giaccherini. Si tratta di un approfondimento di carattere storico-culturale che riflette l’interesse e la sensibilità dell’autore per il tema delle origini etrusche.