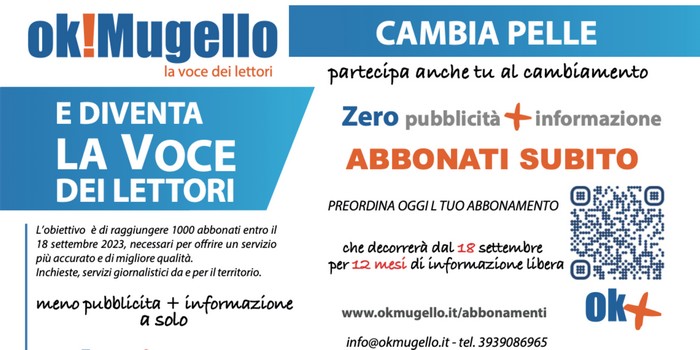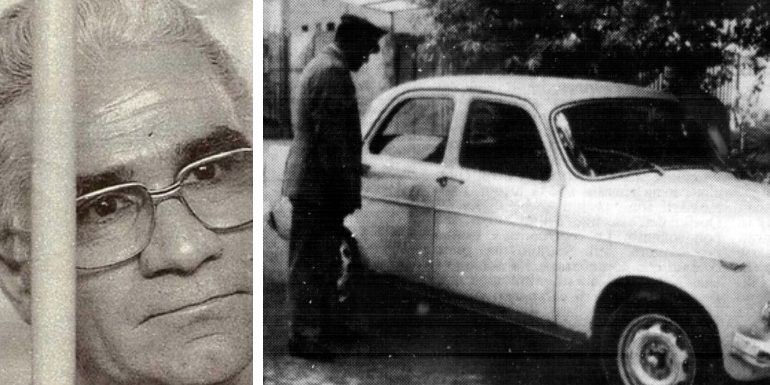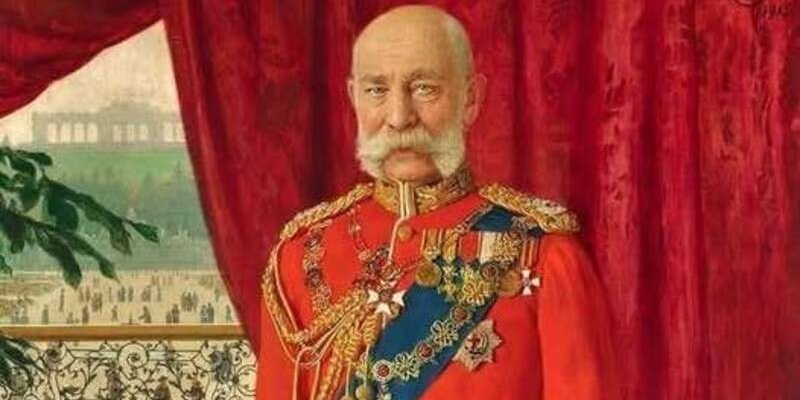Legge 104, si possono richiedere altri 1.200 euro ogni 3 mesi: solo con questi requisiti © N. c.
Legge 104, si possono richiedere altri 1.200 euro ogni 3 mesi: solo con questi requisiti © N. c.
Il disegno di legge dà finalmente valore legale e sociale all’assistenza familiare, con contributi fino a 1.200 euro trimestrali per chi si dedica completamente alla cura.
Il disegno di legge sul riconoscimento dei caregiver familiari segna un passaggio storico nel panorama giuridico e sociale italiano. Dopo anni di silenzio normativo, viene finalmente riconosciuto il valore insostituibile di chi si prende cura di un familiare non autosufficiente, spesso senza tutele, senza stipendio, e con grandi sacrifici personali. Il provvedimento, che attende l’approvazione definitiva del Consiglio dei ministri prima di passare in Parlamento, introduce una classificazione dei caregiver basata sull’intensità dell’impegno assistenziale e apre la strada a forme di sostegno economico, anche se limitate ai casi più gravosi.
Quattro categorie di caregiver e un contributo per chi si dedica totalmente alla cura
Al centro del nuovo testo c’è l’introduzione di quattro profili di caregiver, distinti in base alla quantità di ore settimanali dedicate alla cura di un familiare in stato di non autosufficienza. La classificazione è chiara:
-
Caregiver prevalente convivente: assiste per almeno 91 ore settimanali chi non è autosufficiente.
-
Caregiver convivente: dedica tra 30 e 91 ore a settimana all’assistenza.
-
Caregiver non convivente: pur non vivendo con il familiare, garantisce almeno 30 ore settimanali.
-
Caregiver con carico ridotto: presta tra 10 e 30 ore settimanali, convivente o no.
Solo il caregiver prevalente convivente potrà beneficiare, a partire dal 2027, di un contributo economico fino a 1.200 euro a trimestre, ma a due condizioni: non deve svolgere alcuna attività lavorativa oppure deve avere un reddito da lavoro inferiore ai 3.000 euro lordi annui, e l’ISEE familiare non deve superare 15.000 euro.

Il disegno di legge stabilisce così un primo pilastro normativo per dare visibilità a una figura da sempre ignorata nei testi legislativi, nonostante la sua funzione cruciale all’interno del sistema sociosanitario. In molte situazioni, i caregiver sopperiscono infatti a carenze strutturali dell’assistenza pubblica, assumendosi responsabilità continue, senza ferie né orari.
Il sistema introdotto è definito come “graduato”: significa che si tiene conto del livello di impegno e delle condizioni personali e familiari di chi presta assistenza. Non si tratta ancora di un vero e proprio salario, né di una misura universale, ma di un inizio concreto verso un riconoscimento che si basa su dati oggettivi: ore, convivenza, reddito e carico assistenziale.
Le radici internazionali e il legame con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità
Il disegno di legge italiano si inserisce in un quadro più ampio, in linea con i principi sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata anche dall’Italia. In particolare, l’articolo 2 della Convenzione introduce il concetto di accomodamento ragionevole: quegli adattamenti personalizzati che devono essere messi in atto per garantire piena inclusione e uguaglianza sostanziale per chi vive una condizione di disabilità.
In questo contesto si inserisce anche il Decreto legislativo 62/2024, che ha modificato la Legge 104/1992 con l’introduzione dell’articolo 5-bis, proprio per dare una definizione normativa dell’accomodamento. Le misure devono essere appropriate, non eccessivamente onerose e proporzionate al tipo di tutela richiesta. Un principio che viene ora esteso anche ai caregiver, a partire da quelli più esposti sul piano fisico ed economico.
La Ministra per le disabilità, Alessandra Locatelli, ha sottolineato che “il caregiver non vuole essere sostituito, ma tutelato e sostenuto”. In particolare, la ministra ha evidenziato l’urgenza di riconoscere giuridicamente il caregiver convivente, figura che spesso si occupa da sola dell’intera gestione quotidiana della persona assistita.
Secondo i dati più recenti, sono oltre 8 milioni i caregiver in Italia, spesso invisibili, privi di tutele contrattuali e senza un inquadramento previdenziale specifico. Questo disegno di legge non risolve tutte le problematiche, ma rappresenta un primo passo istituzionale verso una riforma più ampia del welfare familiare.
I prossimi mesi saranno decisivi per valutare l’iter del provvedimento in Parlamento e verificare se il testo subirà modifiche, estensioni o aggiustamenti prima dell’approvazione finale. Di certo, il riconoscimento giuridico e un primo contributo economico rappresentano un segnale politico importante e molto atteso da migliaia di famiglie italiane.